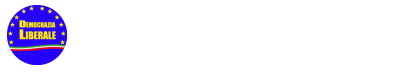IL NUOVO ORDINE MONDIALE SPINGE PER LA DIFESA COMUNE EUROPEA
di Giuseppe Gullo
Siamo ad uno snodo cruciale della politica mondiale dalla fine della Seconda guerra mondiale. L’”ordine” venuto fuori dagli accordi post-bellici aveva subito colpi molto duri che lo avevano via via incrinato. Esso era riuscito tuttavia a resistere, almeno per quanto riguarda l’Europa e gli USA, fino alla spallata decisiva inferta a quella costruzione dall’Amministrazione Trump.
Ovviamente molta acqua era passata sotto i ponti nel corso dei decenni. Il primo fortissimo colpo all’”equilibrio “ post bellico vi era stato in Polonia nel 1980 con la nascita di Solidarnosc e la contestazione sempre più convinta e radicale del modello politico-economico dell’Urss. I tempi non consentirono, per fortuna, allo Stato guida di reprimere militarmente il dissenso come aveva fatto in Ungheria e in Cecoslovacchia. I tempi erano cambiati e un intervento militare sovietico in una nazione cerniera tra est e ovest, con ogni probabilità, non sarebbe stato tollerato. Non dimentichiamo che la Polonia fu nel 1939 il primo Stato occupato dalla Germania nazista che lo riteneva anche geograficamente una sua propaggine. Nella primavera di Solidarnosc ebbe un ruolo decisivo la Chiesa cattolica governata da un Papa polacco che riuscì, con un’opera continua palese e segreta e probabilmente adeguati finanziamenti, a far cadere la pietra angolare che reggeva il regime guidato da Mosca.
Nell’autunno del 1989, con la caduta del muro di Berlino che precedette la riunificazione tedesca, avvenuta nel 1990, e la caduta dell’Urss nel dicembre 1991, la disgregazione dell’URSS si completò. In quel momento uno dei pilastri sui quali si reggeva il sistema mondiale o meglio quello che era stato concepito e realizzato a Yalta, cadde definitivamente aprendo una fase nella quale emersero nuove realtà politiche e territoriali prima inglobate nel sistema comunista, mentre nazioni che avevano mantenuto una formale autonomia furono liberate dal legame con l’est ex sovietico e si avviarono attraverso un processo democratico ad abbracciare il modello occidentale.
Il ruolo dell’alleanza nordatlantica e degli USA fu in quegli anni fondamentale e tale da far ritenere, erroneamente, che l’est europeo fosse definitivamente uscito di scena e che altri e diversi protagonisti emergenti fossero i reali interlocutori, Cina in primo luogo e, a distanza, India. Non è stato così. La Russia, in ginocchio dopo le dimissioni di Gorbačëv e la diaspora politica e territoriale, è risorta dalle sue ceneri e ha riproposto al mondo, con il tragico uso delle armi, la sua atavica volontà di dominio sui territori che un tempo le erano sottomessi. Non tutti forse, certamente quelli non tutelati dalla NATO e quelli ad essa più vicini. L’occidente, USA compresi, ha ignorato il problema o non lo ha capito se non quando è diventato realtà.
Adesso quella parte del mondo che ha avuto i benefici più grandi e il benessere più elevato si trova ad affrontare una crisi epocale in una condizione di grande difficoltà interna e di rapporti deteriorati cogli Stati Uniti d’America, il partner privilegiato e grande tutor degli equilibri costituiti negli ultimi 80 anni.
Sul piano interno sono venuti al pettine i nodi irrisolti del mancato superamento delle sovranità nazionali almeno in alcuni importanti settori come ad esempio quelli fiscale, giudiziario, dell’immigrazione, del mercato del lavoro e del Welfare. Questo ha portato ad una sostanziale impasse che ha nuociuto alla capacità di azione dell’UE fino al punto da far dire a Mario Draghi, in una relazione commissionata dalla Presidenza UE, che è necessario agire subito e con decisione per evitare di procedere verso una fine rapida e ingloriosa.
Già l’abbandono dell’Unione da parte del Regno Unito aveva dato un colpo significativo all’UE per l’ovvia considerazione che è difficile se non impossibile ragionare di politica europea senza l’Inghilterra, come lo sarebbe se non ci fossero l’Italia o la Francia o la Germania. Ancora più grave non avere neppure affrontato il problema di una difesa comune. Quando esso è esploso in tutta la sua complessità, non si è stati in grado neppure di avviarlo in modo da avere un orientamento condiviso verso una sua possibile soluzione. Gli stessi padri fondatori dell’idea della federazione europea nel documento di Ventotene ponevano il problema della creazione di un esercito europeo come fondamentale per la fondazione della futura Europa. Su questo problema non è difficile prevedere che si creerà nell’opinione pubblica anzitutto, e tra le forze politiche, di conseguenza, una spaccatura profonda che potrebbe portare a esiti imprevedibili, alcuni dei quali con effetti dirompenti da tutti i punti di vista.
Quali sono gli aspetti oggettivi dai quali prendere le mosse. Il primo è che la Russia ha invaso una parte del territorio ucraino rivendicandone l’annessione. L’America e l’Europa si sono schierate al fianco del popolo e del Governo della nazione occupata fornendole ingenti mezzi finanziari e armamenti per sostenere lo scontro con una potenza meglio armata e più organizzata. La guerra va avanti da più di tre anni e la sua sorte sembra segnata dopo che l’amministrazione Usa ha dichiarato che intende sospendere il sostegno alle truppe ucraine. È evidente a tutti che senza quel sostegno l’Ucraina non potrà più difendersi ed è destinata a soccombere. Le stesse trattative tra Russia e America per giungere alla conclusione del conflitto dimostrano con evidenza che il Paese aggredito dovrà accettare accordi che saranno stipulati in sua assenza e comunque sulla sua testa, quasi che non fosse il popolo ucraino a dovere subire gli effetti delle decisioni prese. La risposta dell’Europa ancora schierata a sostegno dell’Ucraina e del suo Governo non sembra in grado di orientare lo svolgimento degli eventi non potendo supplire o colmare il gap creato dal preannunciato disimpegno USA.
A questo punto, il discorso torna al quesito iniziale e cioè alla scelta politica fondamentale di andare avanti sulla strada della creazione di un esercito comune degli Stati che costituiscono l’UE, ovvero continuare a finanziare l’Ucraina mantenendo la condizione attuale che è quella per cui ogni Stato ha forze armate nazionali. Il perseguimento della pace è messo in pericolo dalla creazione di una forza militare europea? Qual è la strada migliore per ottenere una condizione di convivenza pacifica? Domande molto complesse rispetto alle quali vi è necessità di liberarsi per quanto possibile da posizioni preconcette e cercare di andare al cuore del problema.
Un primo dato certo è che il dibattito sulla necessità di una forza militare europea si è imposto nel momento in cui si sono verificati due fatti nuovi del tutto imprevisti: l’aggressione militare della Russia all’Ucraina e la preannunciata volontà del Governo americano di ridurre drasticamente o addirittura azzerare i finanziamenti alla NATO. L’invasione russa ha reso evidente l’incapacità dei paesi che costituiscono l’Unione Europea di contrastare sul campo simili azioni, mentre la fine dei finanziamenti USA all’alleanza nordatlantica è il preannunzio della fine dell’ombrello militare e nucleare che ha garantito fin’oggi la sicurezza e l’integrità territoriale delle nazioni del vecchio continente.
Partendo da queste considerazioni oggettive, le risposte che possono essere date dovrebbero essere favorevoli alla costituzione di una forza armata europea. Ciò in quanto il ridimensionamento o la chiusura della Nato renderebbe i paesi europei inermi di fronte al rischio di essere continuamente esposti alla volontà espansionistica della Russia che tende a ricostituire l’impero dissoltosi nel 1991. Non avrebbe neppure alcuna validità l’obiezione avanzata da alcuni secondo la quale il riarmo sarebbe l’anticamera di un nuovo conflitto mondiale, così come è accaduto nel secolo scorso e in particolare in occasione della Prima guerra mondiale. In realtà il cosiddetto riarmo non vi sarebbe in quanto il costituendo esercito europeo non farebbe altro che sostituire la Nato, più o meno con gli stessi compiti e con la stessa funzione. Secondo dati ricavati dal Web, l’Ucraina avrebbe ricevuto 255 miliardi di aiuti economici e/o armi dalla UE, GB e dagli USA per difendere il proprio territorio invaso dalla Russia, e ciò senza che vi sia stato un intervento militare diretto come pure era stato proposto dalla Francia.
La questione va pertanto posta nel modo corretto. L’alternativa non è tra pace e riarmo come se chi propenda per la costruzione di un esercito europeo fosse contrario alla pace. Essa riguarda la necessità di disporre di una forza militare adeguata a difendere, ove ve ne fosse bisogno, l’integrità e l’indipendenza del territorio dell’Unione. Se, per ipotesi, chiusa la crisi Ucraina, la Russia aprisse militarmente un fronte in Finlandia, in Norvegia o in altro Paese, quale dovrebbe essere la risposta dell’Europa? È a questa eventualità che occorre guardare con realismo e lungimiranza per individuare e realizzare le azioni più consone per garantire sicurezza all’Europa.
Fonte Foto: Wikimedia Commons – Esercito Italiano – Licenza